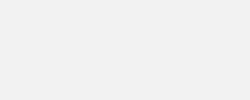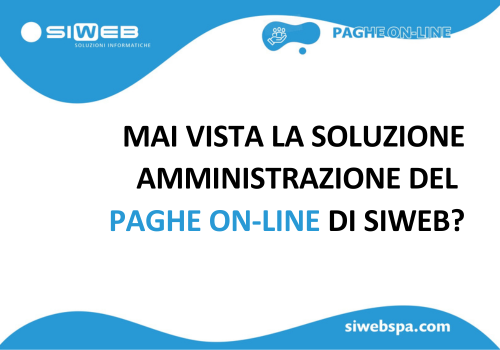La desertificazione commerciale rappresenta la progressiva scomparsa di attività economiche vitali nei territori, con un conseguente impoverimento della qualità di vita per i residenti. Questo fenomeno colpisce in modo diseguale piccoli borghi e grandi centri urbani, lasciando milioni di persone senza accesso a beni e servizi essenziali. Il fenomeno preoccupa molto Confesercenti, che ha condotto uno studio sia sul livello nazionale che su quello regionale, che ci aiutano a capire il fenomeno e la sua portata.
Un po’ di tempo fa avevamo già analizzato il fenomeno a livello nazionale che potete rivedere qui, oggi ci concentreremo su quello che sta succedendo nella nostra regione.
La desertificazione commerciale in Toscana: Un fenomeno in crescita
Secondo un’analisi dettagliata condotta in Toscana dallo studio di Confesercenti, tra il 2014 e il 2024 sono oltre 1,3 milioni i residenti ad aver visto la chiusura definitiva di almeno un’attività di base nel loro comune. Minimercati, panetterie, tabaccherie, librerie, e persino distributori di carburante sono sempre più rari, creando difficoltà economiche e sociali. I piccoli comuni, spesso già gravati da spopolamento e declino economico, risultano i più colpiti,allargando il divario tra aree urbane e rurali.
La chiusura delle attività commerciali genera conseguenze significative: dall’aumento degli spostamenti per accedere ai servizi, alla perdita di posti di lavoro locali, fino alla riduzione delle entrate fiscali per i comuni. Nelle grandi città, il fenomeno assume contorni differenti: alcune attività vengono sostenute dall’imprenditoria straniera o sostituite dai servizi digitali, mentre cresce la turisticizzazione, con un incremento delle strutture ricettive extra-alberghiere.
L’analisi di Confesercenti si concentra su attività essenziali come minimercati, panetterie e negozi di elettrodomestici e mostra un quadro preoccupante: in molti comuni la mancanza di queste imprese penalizza fortemente la popolazione locale. Ad esempio, il commercio di elettronica manca in 36 comuni, interessando oltre 200.000 residenti, mentre la vendita di latte e prodotti caseari è assente in 19 comuni, colpendo 214.000 persone.
Questa crisi del commercio di vicinato non è solo sintomo di cambiamento economico, ma anche un richiamo all’importanza di politiche mirate a tutelare le attività locali, garantendo servizi essenziali alle comunità e promuovendo la coesione sociale oltre che la tutela dei piccoli centri, contrastando lo spopolamento e avvicinando servizi pubblici e privati per aumentare la qualità della vita.
I dati Confesercenti: analisi del declino commerciale
L’Italia è nota per il suo assetto insediativo policentrico, caratterizzato da una rete di piccoli comuni e borghi. Anche la Toscana riflette questa tendenza, con 273 comuni di cui la maggioranza (119) conta meno di 5.000 abitanti. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, la regione ha affrontato cambiamenti demografici e commerciali significativi.
Tra il 2014 e il 2024, l’Italia ha registrato una perdita di oltre 1,3 milioni di residenti (-2,17%), un fenomeno che ha colpito maggiormente i comuni con meno di 15.000 abitanti (-5,4%). La Toscana ha seguito questa tendenza, perdendo circa 74.000 residenti (-2%). Lo spopolamento è più evidente nei micro-comuni sotto i 5.000 abitanti (-6%), nei centri tra 10.000 e 15.000 abitanti (-2,5%) e persino nei nuclei urbani più grandi (-3,5%). I comuni di dimensioni medio-piccole e medio-grandi risultano invece più resilienti.
Parallelamente, il commercio al dettaglio in Toscana ha subito un netto declino: nel 2024 si contavano 47.407 attività, con una diminuzione di 8.474 unità (-15,2%) rispetto al 2014, un calo superiore alla media italiana (-13,6%). Il fenomeno colpisce in modo più marcato i micro-comuni (-18,5%) e quelli con 5.000-15.000 abitanti (-16,9%). Anche le grandi città non sono immuni, con una riduzione delle attività commerciali di vicinato.
Quali settori sono più colpiti?
La desertificazione commerciale è particolarmente critica per settori come il commercio di latte e prodotti caseari (-50%) e l’elettronica di consumo (-44,8%). Sono diminuite anche altre attività essenziali, come minimarket (-24,5%), ferramenta (-20,4%) e rivendite di giornali (-34%). Al contempo, settori come le panetterie (+33,3%) e l’abbigliamento per adulti (+34,2%) hanno registrato una crescita, frutto di dinamiche di sostituzione tra imprese.
Questo quadro evidenzia sfide significative per le comunità locali in termini di accesso ai servizi e coesione sociale. Per contrastare lo spopolamento e preservare la vitalità economica dei territori, sono necessarie politiche mirate.
Il fenomeno della desertificazione commerciale varia significativamente tra comuni piccoli, medio-piccoli e medio-grandi, evidenziando una tendenza generale alla contrazione delle attività di vicinato. Vediamo un po’ di dati ricavati dallo studio Confesercenti:
Piccoli Comuni (5.000-15.000 abitanti)
Con 99 piccoli comuni e oltre 908.000 abitanti, questa fascia ha perso quasi 1.200 attività tra il 2014 e il 2024, segnando un calo del -13,9%. I settori più colpiti includono: negozi di latte e prodotti caseari (-41,7%), edicole e rivendite di giornali (-40,4%), elettrodomestici ed elettronica di consumo (-32,5%).
Crescono, invece, i negozi di abbigliamento per adulti (+30,8%), anche se il saldo complessivo del settore moda rimane negativo.
Comuni Medio-Piccoli (15.000-50.000 abitanti)
Questi comuni ospitano oltre un milione di residenti e mostrano una relativa stabilità demografica (-8.000 abitanti tra 2014 e 2023). Tuttavia, le attività di base sono diminuite del -8,9%, con una perdita di quasi 900 imprese in dieci anni. Dal 2019 in poi, il calo è stato particolarmente rapido (-8%). Le latterie subiscono il crollo maggiore (-56,3%), seguite dalle edicole (-37,6%) e dai minimarket (-15,2%). In controtendenza, empori (+6,5%) e tabaccherie (+8,9%).
Comuni Medio-Grandi (50.000-250.000 abitanti)
Con 11 comuni e oltre un milione di residenti, questa fascia registra un calo del -13,5% nel numero di attività di vicinato, con 1.420 imprese scomparse tra il 2019 e il 2024. Tra i settori più colpiti si segnalano: edicole e rivendite di giornali (-41%), elettronica ed elettrodomestici (-40%), ferramenta (-30,2%).
Generi di monopolio (+3,5%) e abbigliamento per adulti (+34,6%) segnano una crescita positiva.
Firenze, l’unica metropoli
Il capoluogo toscano conta 3.760 attività di vicinato nel 2024, registrando una perdita del -13,4% dal 2014, con un impatto maggiore post-pandemia. I settori più penalizzati includono: latte e prodotti caseari (-47,8%), elettrodomestici (-42,2%), macellerie (-40,3%). In controtendenza, tabaccherie (+6,5%) e abbigliamento per adulti (+18,7%).
Strategie per contrastare la crisi del commercio locale
Questo quadro sottolinea l’urgenza di politiche mirate per sostenere le attività di vicinato nei diversi contesti comunali, preservando il tessuto economico e sociale della Toscana. Confesercenti ha
anche presentando proposte direttamente al governo, elencate con chiarezza in occasione della presentazione dello studio, sono leggibili in questo articolo.